Luisa Carnés, Tea rooms. Operaie della ristorazione, trad. di Alberto Prunetti, Alegre, Roma 2021, pp. 62-65.
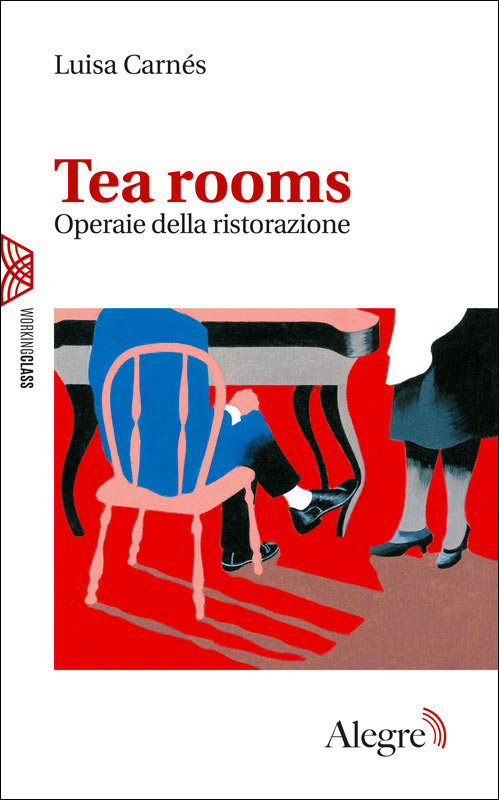
Siamo in Spagna negli anni Trenta del Novecento. Felisa è stata appena licenziata dal proprietario del ristorante in cui lavorava e le sue colleghe Trini e Matilde sono indignate e preoccupate. Il licenziamento di Trini fa nascere in Matilde una riflessione sulla sua situazione personale, sul suo passato e sulla condizione della società del suo tempo.
Trini è ancora indignata col locale e il proprietario. Il licenziamento di Felisa, ingiustificato agli occhi di tutte le inservienti, aumenta ancora di più la sua rabbia. «Se lo hanno fatto a lei che lavorava qui da più di tre anni, cosa faranno a un’inserviente appena arrivata?». «Lo stesso. Qui gli anni di servizio e il buon comportamento non contano nulla. Guarda me: sono qui da sedici anni. Ma se solo per un attimo dovessi trascurare qualcosa…».
Matilde aiuta Trini a sistemare i cioccolatini. Non interviene nella conversazione se non per monosillabi. Pensa alla propria situazione, cambiata di poco. Ha smesso di andare in giro inquieta e penosa. Il suo passo è più sicuro e spedito. Ma per il resto, in casa li cibo è migliorato di poco e l’atmosfera, in generale, è la stessa. La sua concezione della vita non è cambiata, anzi. Si è consolidata anche la sua idea di società divisa in due: «C’è chi sale con l’ascensore e chi deve prendere la scala di servizio».
Non si arriva a una definizione tanto concreta senza una lunga esperienza di umiliazione e dolore: senza prima aver toccato, aver soppesato il valore di queste due parti. Due metà che in linea di massima fingono di formare un solo corpo, indivisibile. Solo in apparenza, perché la divisione esiste: la divisione esiste fin dal principio, fin dai secoli dei secoli. Ma quei piccoli occhi deboli, abituati all’oscurità più misera, non conoscono che una sola delle due metà e non possono compararle. Quei piccoli occhi che scrutano interrogativi, che spuntano da luoghi scialbi e brutti – cortili scuri pieni di fumo e polvere provenienti da cucine misere – sono troppo ingenui, troppo inesperti; variano poco, si distinguono appena gli uni dagli altri: identico il colorito, i cibi insipidi, i vestiti usati ceduti da bambini più fortunati. Da un’alta finestra si vedrebbe giocare nel piccolo cortile quello che sembra un compendio dell’universo intero. Anzi: un frammento della sua metà oscura. I giocattoli sono vecchie pentole, catini pieni di fori, ormai inutilizzati. Sembra che al mondo non esistano altri giocattoli che “questi”. Ma si sa che esistono. A volte li hanno visti in qualche vetrina o tra le mani dei bambini “ricchi” – ecco la magica parola che li divide. Ma al bimbo già sembra normale che i giocattoli appartengano a chi se li può permettere. E pensa anche sia ovvio che le sue mani, come quelle degli altri membri della piccola ciurmaglia che grida e gesticola lì in cortile, siano sempre livide e screpolate dal freddo. Perché anche le mani enormi dei “grandi” sono arrossate e rovinate. Ma capita poi a volte di vedere all’improvviso davanti ai propri occhi mani rosee e profumate – in uno di quegli incroci casuali che accadono per strada – e allora si comincia a scorgere, per quanto ancora incerta e confusa, la linea divisoria. Via via che si cresce la linea acquista rilievo, prende corpo. E quando si diventa grandi e si inizia a lavorare, all’improvviso le due metà si presentano chiare davanti agli occhi: una è brillante; ma l’altra, quella scura, è ormai così tanto parte della propria vita che per vederla bisogna aprire bene gli occhi e confrontarla con l’altro mondo, e allora… sembra allora che nasca qualcosa, che cresca in maniera più netta, solidificandosi. Avviene per esempio quando si entra in un grande atelier di moda dove tutti ti comandano, dove bisogna accettare ogni imposizione, dove per ogni più piccola cosa c’è subito la possibilità di essere licenziate. Un licenziamento? Bene: lì si guadagnano cinquanta centesimi al giorno. Tre pesetas alla settimana. Ma «si impara a guadagnarsi da vivere». «Il mestiere bisogna guadagnarselo». Guadagnarselo con le lacrime e le umiliazioni. Perché anche la piccola figlia “della signora” da cui si sta andando a bottega prova gusto a deriderti. La figlia “della signora” torna ogni sera a casa col comodo autobus del collegio francese e con un salto si infila in ascensore. Entrando lancia alla piccola apprendista il cappello e la cartella coi libri. «Tieni, ragazza, portali dentro». «Dentro» è la residenza privata “della signora”, separata dall’atelier da un lungo corridoio scuro. «Dentro» ci sono morbide poltrone di pelle, bei quadri, credenze piene di porcellane e cristalli, e posate d’argento su tavolini smaltati decorati di madreperla. «Dentro» l’ambiente è gradevole, caldo, confortevole. Ha un buon profumo che preannuncia cibi saporiti. Ma anche le domestiche sono autoritarie e brontolone con la piccola apprendista. «Ohi, porta la merenda alla piccola». La «piccola» è più grande dell’apprendista, e forse è anche più brutta. L’apprendista le porta la merenda nel laboratorio dove la “signorina” va a nascondersi, desiderosa di ascoltare i racconti piccanti delle sarte, mentre “mammà” è nella sala dove si provano i vestiti. La merenda di solito consiste in un panino al prosciutto e un bicchiere di latte. lI corridoio è lungo e scuro e l’apprendista ha la pancia vuota. Ma per quanto sia piccola conosce i propri doveri. Al massimo annusa il profumo del panino, ma non va mai oltre. Diverso è quando riporta il bicchiere in cucina: allora l’apprendista beve quel che resta del latte e mangia le briciole rimaste nel piatto. In questi momenti, dopo aver sorbito la prima goccia clandestina e aver divorato la prima briciola, sembra che nasca qualcosa, che qualcosa prenda corpo. La linea divisoria appare all’improvviso con tutto il suo spessore, con tutta la sua forza. All’improvviso capisce di odiare la “signorina”, l’argenteria e i cristalli di quella sala da pranzo. Arriva a odiare anche il calore confortevole di quell’ambiente. E pensa di “loro” tutto il peggio possibile. Tutto ciò che di piacevole li circonda, svanisce. Pensa solo alle cose brutte. All’improvviso si ricorda di quella sera in cui ebbe l’impudenza di entrare nel “loro” bagno, mentre la “piccola” usciva. Uff! Ricorda che rientrò in laboratorio con una mano sul naso (che schifo!). E che le operaie si misero a ridere: «La merda dei ricchi puzza come la morte!». La linea divisoria compare in tutta la sua forza. Anche se non sa ancora definirla a parole, la vede, la sente in ogni istante. Sopratutto all’ora di pranzo, nella mezz’ora di cammino per tornare a casa passando per strade pulite e file di grandi case con giardini con della ghiaietta cosi chiara e brillante che sembra riso. Passando davanti alla servitù in livrea ben retribuita. I dolci e squisiti odori che si spandono dalle cucine dei ricchi, il calore provocante che la circonda quando passa sotto le finestre ricordandole che ha mangiato, alle otto del mattino, solo una tazza di caffè nero e un pezzo di pane raffermo, e ormai sono le due del pomeriggio. Ricordandole che la sua fame non è la fame di qualche ora o di qualche anno: è la fame di tutta una vita, sentita attraverso generazioni di antenati poveri (e a casa l’aspetta un piatto di patate con qualche sparuto pezzetto di baccalà). E ricorda una volta quando, dopo aver chiesto un indirizzo a uno di quegli antipatici portieri in livrea, la fecero entrare «per la scala di servizio». Un concetto concretizzatosi in parole. La linea divisoria di classe adesso è fissata definitivamente (o chissà, forse solo per un tempo limitato?).
Matilde sente adesso, più forte di prima, il peso della propria condizione di sfruttata. Il licenziamento della sua compagna la riempie di tristezza. Sarebbe stato giuridicamente giusto, e umano, protestare, esigere il reintegro sul posto di lavoro dell’inserviente licenziata. Ma non si può fare affidamento sulla collaborazione delle altre. Antonia, dopo lunghi anni di penose umiliazioni, non è riuscita neanche a ottenere dai superiori il riconoscimento dei propri diritti di impiegata esperta. Non si può contare su Trini: neanche per ipotesi potrebbe rischiare di perdere le sue ventuno pesetas settimanali. La paga giornaliera della madre come lavapiatti non basta neanche a mangiare male.
Tea rooms. Operaie della ristorazione di Luisa Carnés nella traduzione di Alberto Prunetti è pubblicato da Alegre.
QUESTO BRANO È UTILIZZATO PER L’ATTIVITÀ n° 8 DEL KIT DIDATTICO PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO DELLA SECONDARIA DI II GRADO.

