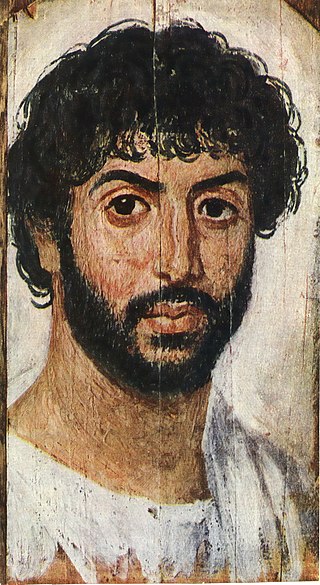
Luciano di Samosata, Il sogno. Il gallo. L’asino, trad. di Claudio Consonni, Mondadori, Milano 1994.
Siamo in Siria, intorno al 163 dopo Cristo. Luciano di Samosata (120-190 ca.), filosofo e retore professionista ormai affermato, torna nella sua terra natale, che aveva abbandonato in tenera età per inseguire il suo sogno di fare il letterato. Adesso ha poco più di quarant’anni, e in un discorso di fronte al pubblico dei concittadini ricostruisce, attraverso un lungo flashback, le prime tappe della sua carriera, quando questa appariva ancora come un punto interrogativo. Il brano, scritto in greco antico, è tradotto da Claudio Consonni.
Questo è l’inizio del brano da leggere (pp. 9-15):
Da poco avevo terminato di frequentare la scuola primaria, ero ormai sulla soglia dell’età dell’adolescenza, e mio padre discuteva con i suoi conoscenti sull’educazione da impartirmi. La maggioranza ritenne che le lettere, in verità, abbisognano di grande impegno, molto tempo, spesa non piccola, e di uno status sociale all’altezza; la situazione della nostra famiglia, peraltro, era modesta, e tale da aspettarsi un mio contributo in tempi brevi. Nel caso, invece, che apprendessi un comune mestiere artigianale, dal lavoro avrei avuto subito un reddito sufficiente, senza più essere – all’età che avevo – a carico della casa; e, in breve tempo, avrei fatto felice mio padre offrendogli di volta in volta i risparmi accumulati.
Per cui si discusse, in seconda istanza, per vedere quale tra i due mestieri fosse il più valido, di più facile apprendimento, confacente a un uomo di nascita libera, con il necessario a portata di mano ed entrate adeguate. È naturale che ciascuno, a seconda della propria mentalità o esperienza nella pratica, ne promuovesse uno diverso; mio padre, rivoltosi allo zio – era presente lo zio materno, il quale aveva rinomanza d’eccellente scultore [lavoratore della pietra tra i più celebri] – gli disse: «Sarebbe un delitto avere qui te, e far prevalere un’arte differente dalla tua: anzi, portalo via,» e indicava me «prendilo con te e insegnagli ad essere un bravo lavoratore con la pietra, a saperne combinare tipi diversi, a scolpirla. Ne possiede le potenzialità: la natura – sai – è stata propizia».
Questa convinzione gli era nata dalle cose che i bambini fanno per gioco con la cera. Dovete sapere che, quando terminavo la lezione, raschiando la cera usavo creare figure di buoi, cavalli, anche – proprio così – persone: una riproduzione piuttosto fedele, tale la considerava mio padre. Le figurine, che mi erano costate botte dai maestri di scuola, in quel momento divennero dunque anch’esse motivo di esprimersi con favore sulle mie doti naturali, e mi si accreditava con buone speranze che avrei imparato in breve il mestiere. Così almeno a partire da quei lavoretti con la cera.
Non appena il giorno fu ritenuto opportuno perché fossi iniziato all’arte, eccomi consegnato allo zio, senza che – Zeus è testimone! – la cosa mi disturbasse particolarmente, anzi mi sembrava un gioco non spiacevole, nonché un modo per mettermi in mostra con i miei coetanei, come quello che scolpisce immagini di dei e crea piccole statuine per sé e per quanti ha prescelto. L’inizio fu quello solito per i principianti; lo zio mi diede un piccolo scalpello e mi assegnò il compito di battere su una lastra di pietra posta di fronte, con giudizio. E aggiunse: «Il principio è metà del tutto», come si usa dire. Io per inesperienza colpii troppo forte, la lastra restò spezzata, lo zio, in preda all’ira, tirò su un randello appoggiato il vicino e mi consacrò all’arte lasciando stare le gentilezze e le esortazioni benevole. La mia attività di scultore si apriva tra le lacrime.
Fuggito di lì, arrivo a casa singhiozzando ininterrottamente, con gli occhi pieni di lacrime, racconto del randello, e, mentre mostravo i lividi, lo accusavo di eccessiva crudeltà, aggiungendo che l’aveva fatto per invidia, per paura che lo superassi nell’arte. Per consolarmi mia madre mandò a dire molte brutte cose al fratello; la sera scese e presi sonno ancora in lacrime, con il pensiero fisso sul randello.
Certo, fin qui la storia è infantile, e mette il sorriso; ma nel prosieguo – gente, dico a voi – ascolterete cose che non è possibile non prendere sul serio, al contrario, richiedono un uditorio ben avvisato. Perché, per dirla con Omero,
nel sonno sogno divino venne a me
attraversando la notte immortaletanto suggestivo da non risultare inferiore alla realtà. Effettivamente ancora oggi, passato tanto tempo, i contorni dell’apparizione restano nei miei occhi, e il suono delle parole udite mi è fresco, tale era la lucida evidenza dell’insieme.
Due donne, afferrandomi con le due mani, cercavano di trascinarmi con gran piglio ed energia, ciascuna dalla propria parte; tant’è vero, ci mancò poco che mi strappassero a mezzo, nel loro litigio: ora prevaleva l’una, e, per un attimo, si trovava unica padrona di me, ora, all’inverso, ero tenuto dall’altra. Si scambiavano grida: diceva al prima che ero di sua proprietà, e di essere intenzionata a godere del suo possesso, la rivale replicava a lei che il tentativo di appropriarsi della cosa altrui sarebbe fallito. Una era modellata dal lavoro, virile, i capelli insudiciati, le mani coperte di calli, al veste stretta dalla cintura, tutta piena di polvere di marmo come lo zio quando lavora la pietra; l’altra aveva fattezze estremamente dolci, abbigliamento di classe, e un armonioso contegno nel portare la veste. Alla fine, lasciano a me di pronunciare il verdetto su quale di loro due volessi per compagna.
La signora austera, e virile, parlò per prima:
«Io sono Scultura, figlio mio, l’arte che ieri hai cominciato a conoscere; io sono di famiglia con te, consanguinea per parte di madre, perché tuo nonno» e qui dice il nome del nonno materno «lavorava con la pietra, come i tuoi due zii i quali, grazie a me, godono di ottima reputazione. E se vuoi tenerti a distanza dai futili sproloqui di costei,» indicando l’altra «se vuoi seguirmi e trattenerti con me, in primo luogo, verrai tirato su vigorosamente e avrai spalle robuste, sarai al di fuori da ogni invidia e non ti capiterà mai di partire per un’altra terra abbandonando la tua patria e i tuoi cari, né, poi, tutti si complimenteranno con te sulla base di parole […]»
Queste e altre cose ancora diceva l’Arte, fra ricorrenti inciampi della lingua ed espressioni poco corrette, con grande zelo peraltro nel presentare una serie di argomentazioni, e tentando di convincermi; ma non ricordo più: gran parte, ormai, è caduta nella memoria.
Non appena si fermò, comincia l’altra, più o meno così: «Se invece dai retta a me, innanzitutto ti presenterò molte opere di uomini antichi e azioni meravigliose, trasmetterò le loro parole, ti renderò esperto praticamente di tutto, e abbellirò il tuo spirito – la cosa il cui ruolo per te è capitale – di molti ornamenti di valore: temperanza, senso di giustizia, rispetto, mitezza, cordialità, intelligenza, forza d’animo, amore del bello, tensione verso il sublime. Perché questi sono i gioielli dello spirito, quelli autentici. Nulla che sia antico ti sfuggirà, né alcunché sia destinato ad accadere presentemente, anzi, insieme a me vedrai in anticipo anche il futuro; per dire tutto in uno, di qui a poco ti insegnerò tutto quanto è, le cose degli dei e le cose degli uomini. […] Se ti lasci sfuggire uomini di tale grandezza e qualità, azioni luminose, parole cariche di solennità, un abbigliamento lussuoso, onore, gloria, lode, posto d’onore, potere e funzioni pubbliche, e la celebrità per le doti di eloquenza, e i complimenti per quelle d’intelligenza, all’inverso vestirai uno squallido grembiule, il tuo aspetto sarà quello di uno schiavo, maneggerai sbarrette per far leva, arnesi per cesellare, tagliare e scolpire, con il capo chino sull’opera, terra terra abietto e in ogni modo degradato, senza mai rialzare la testa, senza un pensiero da vero uomo, da uomo libero; sarai attento a che i lavori vengano belli, e con i giusti equilibri, senza minimamente preoccuparti affinché la tua persona abbia in sé armonia, e i giusti equilibri, facendo, anzi, minor conto di te che non della pietra…».
Lei andava avanti a parlare, ma io non aspettai la fine del discorso: alzandomi in piedi esposi il verdetto, abbandonai la donna non bella, l’operaia, e passai ben lieto con Cultura […].
QUESTO BRANO È UTILIZZATO PER L’ATTIVITÀ n° 1 DI TUTTI I KIT DIDATTICI.

